
La sesta estinzione di massa
Elizabeth Kolbert, già autrice di Field Notes from a Catastrophe, si supera nel suo nuovo libro The sixth extinction (versione italiana: La Sesta Estinzione). Con una narrativa strepitosa, ci porta...
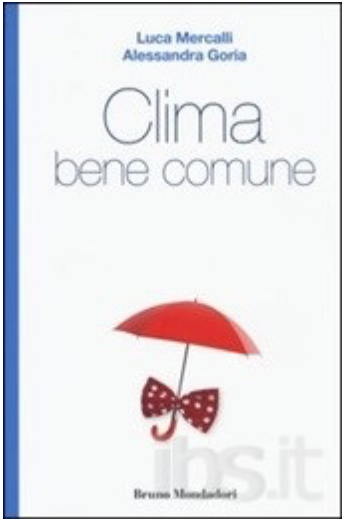
Clima, bene comune
Il libro di Luca Mercalli e Alessandra Goria (Bruno Mondadori, 2013) offre un interessante punto di vista sulla questione climatica; non solo sugli aspetti fenomenologici, ma sui collegamenti e...
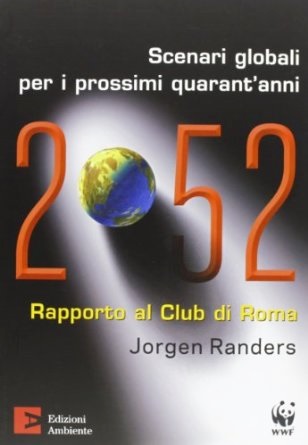
“2052”, ritorno al (grigio) futuro
Un nuovo meditato scenario di Jørgen Randers sul futuro che ci aspetta se i decisori non decidono e prevale l’inerzia. Mentre l’IPCC analizza, commenta e riassume tutte le posizioni...
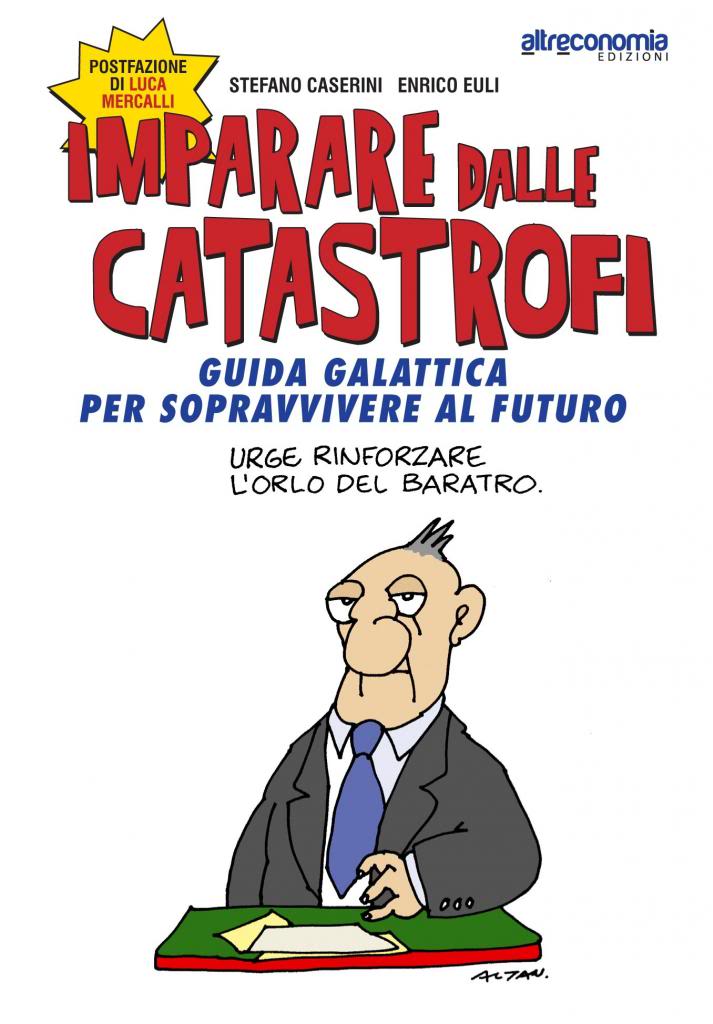
Imparare dalle catastrofi
Due libri a disposizione di chi vuole riflettere sul tema della catastrofe senza dar retta alle stupidaggini sulle presunte previsioni dei Maya Da tempo mi è capitato di notare...
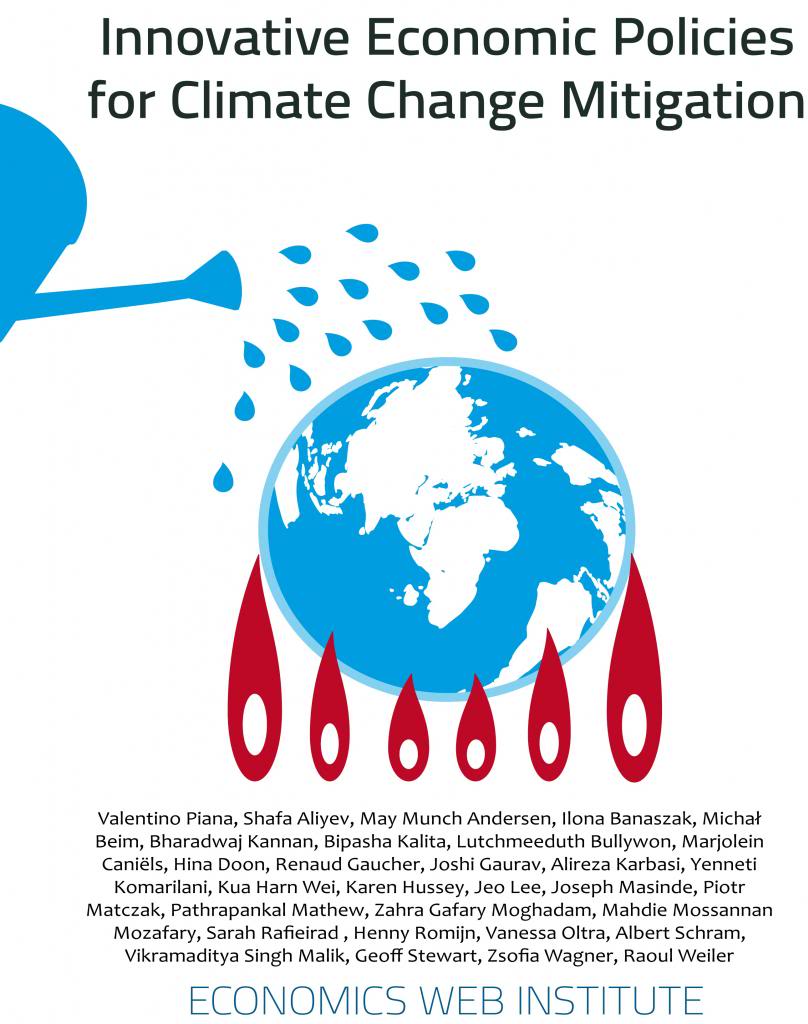
Come accelerare la mitigazione dei cambiamenti climatici
Esce su Amazon.it la seconda edizione di “Politiche economiche innovative per la mitigazione dei cambiamenti climatici”, aggiornata con le prime implementazioni all’estero ed in Italia. Un lavoro collettivo di oltre...

Caligola, Lucifero e… Bernacca…
Chissà se questa nuova tendenza dei siti di previsioni meteorologiche glamour sarebbe piaciuta al Colonnello Edmondo Bernacca, figura storica di un’Italia che negli anni del secondo dopoguerra veniva unificata dalla...
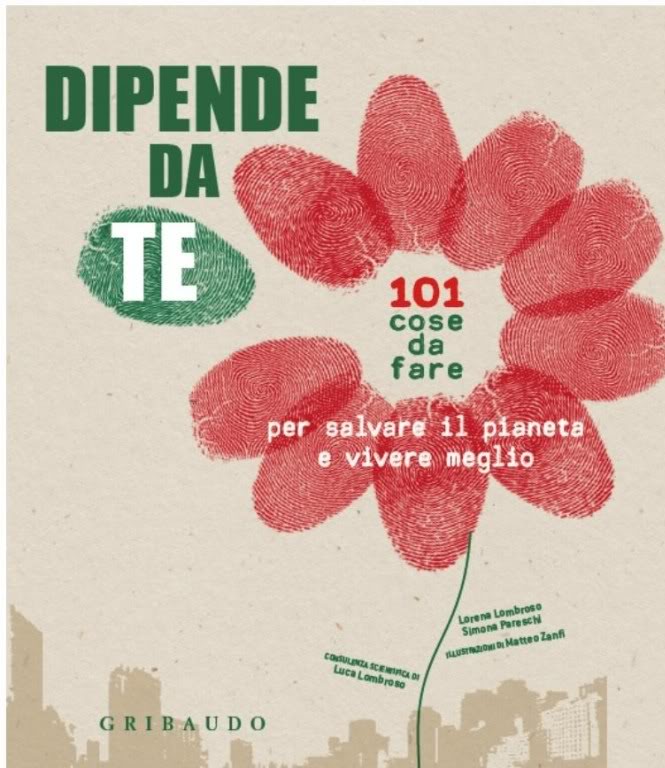
Dalle azioni individuali di mitigazione un contributo per il clima?
Per ridurre le emissioni di gas erra e vivere meglio, un libro con 101 ricette d’azione individuale e familiare. Ma se le cose da fare sono chiare, come far sì...
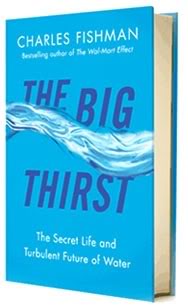
La grande sete
Tra cambiamenti globali e ragioni locali, la risorsa acqua è minacciata. Il libro La grande sete tratta un tema chiave per l’adattamento e per la sopravvivenza della specie umana. È...
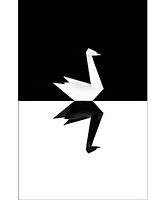
Il cigno nero del clima
La storia è piena di eventi unici ed estremamente impattanti ritenuti imprevedibili a priori. Sono quelli che Nassim Nicholas Taleb, noto filosofo empirista ed operatore di borsa, definisce “cigni neri”....
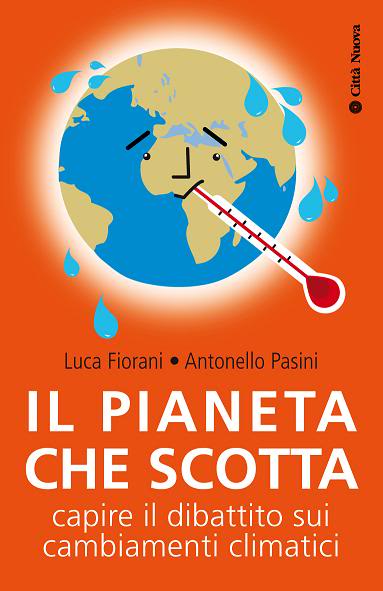
Un pianeta e un dibattito che scotta
Climalteranti ha creato una pagina LIBRI in cui sono riportate le recensioni e il materiale di supporto di libri consigliati o scritti dai componenti del Comitato Scientifico. Questo post ne...