
Gli ostacoli cognitivi ai cambiamenti climatici
Perché si fatica a comprendere il problema dei cambiamenti climatici – e ancora di più a reagire? . Il problema dei cambiamenti climatici si è rivelato negli anni particolarmente difficile...

Appuntamenti sul clima in settembre
Mentre sui quotidiani trovano spazio tesi infondate sul ruolo dei gas serra o idee improbabili su come risolvere il problema, nel mese di settembre sono previsti numerosi appuntamenti per approfondire...

In ricordo di Steve Schneider
Il 19 luglio è scomparso Stephen Schneider, una persona che ha dato un contributo importantissimo allo studio dei cambiamenti climatici e alla divulgazione pubblica dei risultati della scienza del clima....

L’invenzione delle contrapposizioni scientifiche
Pur se non mancano punti da meglio chiarire sia sul tema dei cambiamenti climatici che sulla teoria dell’evoluzione, l’esistenza del disaccordo scientifico su questi temi è in larga parte il...

Quattro regole per il blog
Da quando è nato, questo sito ha “scommesso” sulla capacità dei lettori del blog di automoderarsi, di permettere un confronto sereno e costruttivo. Abbiamo lasciato le briglia sciolte, la massima...

Climalteranti compie 1 anno
Climalteranti compie un anno di vita ed è tempo dei primi bilanci. . Partiamo dai numeri: il sito è stato visto 61.000 volte, con un record di 746 viste l’11...

Il 1912.. praticamente ieri
Le argomentazioni negazioniste sul clima sono a volte complesse e richiedono spiegazioni interessanti ma un po’ impegnative (un esempio in questa traduzione di Realclimate). Altre volte sono semplici e già...

Due Appuntamenti
Si svolgeranno questa settimana due incontri pubblici che hanno come tema le conoscenze e le incertezze sui cambiamenti climatici, il cuore dei contenuti di Climalteranti.it. Tutti i lettori sono invitati,...
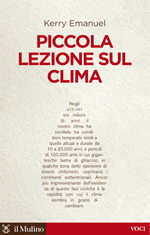
Un bel libro con una Prefazione poco aggiornata
Fra i libri più belli pubblicati negli ultimi anni sui cambiamenti climatici va senza dubbio citato “Piccola lezione sul clima” di Kerry Emanuel, professore di Scienze dell’Atmosfera al MIT di...

Esiste una “clausola di revisione” del Pacchetto 20-20-20 ?
Al di là delle vistose carenze nella comprensione del problema dei cambiamenti climatici, la mozione approvata dall’aula del Senato contiene alcuni errori basilari nel ricostruire gli impegni assunti dall’Italia e...