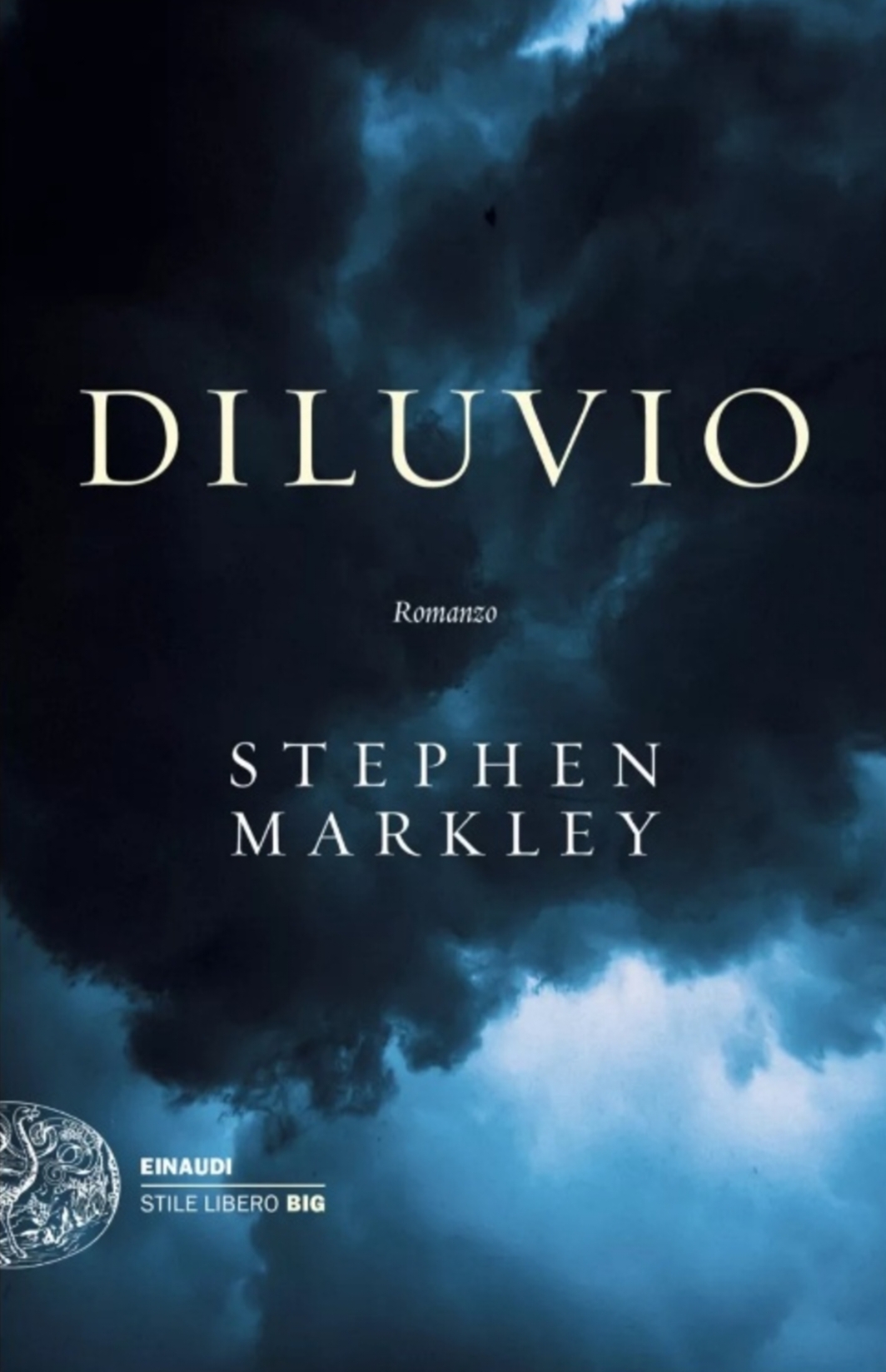
Nel suo fortunato saggio La grande cecità, lo scrittore Amitav Ghosh aveva osservato come la letteratura contemporanea avesse ignorato o quantomeno sottovalutato il tema del cambiamento climatico. Secondo lo scrittore indiano, “Il cambiamento climatico è troppo impensabile per la nostra cultura narrativa; la sua esclusione è una delle forme di “cecità” della nostra epoca.”. Secondo Gosh, pensare alla crisi climatica come qualcosa di eccezionale, improbabile e non realistico, porta scrittori e in generale gli intellettuali a relegarla nel genere della fantascienza, o dei romanzi di genere catastrofici e distopici, porta all’incapacità di immaginare e quindi di raccontare l’impatto reale e quotidiano della crisi climatica, le sue possibili evoluzioni e le sovrapposizioni con altre crisi sociali, economiche, geopolitiche, militari, alimentari.
***
Il romanzo “Diluvio” di Stephen Markley risponde in pieno a questa critica di Gosh. Un libro portentoso, in cui la crisi climatica è il filo conduttore della narrazione, complessa e solida dal lato scientifico-climatico, molto più di quanto siamo abituati a leggere nei romanzi. Un’opera spaventosamente attuale, in cui si ritrovano in un intreccio avvincente moltissime delle questioni che compongono oggi il dibattito culturale, politico e tecnologico sul cambiamento climatico.
Ambientato negli Stati Uniti nel periodo 2028-2040, Diluvio racconta innanzitutto in modo magistrale l’incedere delle devastazioni legate al cambiamento climatico, con un realismo a tratti profetico (l’episodio sugli incendi di Los Angeles nel 2031 è stato scritto almeno tre anni prima dei grandi incendi del gennaio 2025), e per questo inquietante. Racconta anche quali potrebbero essere gli impatti futuri, come ci potrebbero essere sorprese che già si stanno studiando (il primo capitolo del libro si intitola “Le transizioni di fase degli idrati di metano”).
Ma il cuore del libro è sulla categoria che siamo soliti definire mitigazione, ossia le azioni per cambiare strada e ridurre le emissioni climalteranti, per contrapporsi alla tendenza in atto. Tentativi diversi, da parte di attivisti, giovani in particolare, di organizzazioni ambientaliste, delle forze politiche, dei funzionari governativi, delle mobilitazioni delle persone più o meno disperate. In certi momenti il libro diventa una sorta di manuale delle azioni da mettere in campo per contrastare la crisi climatica, con interessanti proposte di progetti di leggi sul clima, dettagliate quanto fondate per gli aspetti tecnico-scientifici.
La forza e la novità dell’opera di Markley è nel mostrare in modo approfondito la complessità della risposta alla crisi climatica, le possibili strategie, i diversi punti di vista, le contraddizioni, le inevitabili collusioni, i punti di forza e di debolezza delle strategie violente o nonviolente, delle mobilitazioni e del lavoro dei think tank più o meno ambientalisti. Senza soluzioni miracolistiche, senza la retorica a buon mercato sulla speranza che ammorba molto spesso il dibattito sul clima. Un’opera-mondo, è stata definita, che mostra in modo realistico una possibile evoluzione della crisi climatica, fatta di instabilità politica, rivolte sociali, collasso economico e aumento delle diseguaglianze.
Il romanzo mostra come la risposta tecnologica, che pure è importante ed è considerata nel libro (è forse il primo romanzo in cui si parla anche di rimozione della CO2 atmosferica!), è solo una parte della storia. Il cuore dell’epica di Diluvio sono le debolezze del sistema politico-istituzionale, la disperazione e la determinazione dei giovani, la ferocia repressiva dei governi minacciati dal cambiamento, il solido potere del mondo finanziario, le interferenze delle lobby fossili, gli aspetti inquietanti del controllo sociale delle nuove tecnologie.
***
Senza entrare nel merito degli aspetti stilistici e letterari (si vedano al riguardo altre recensioni, ad esempio Matteo Meschiari su Doppiozero, Antonio Galetta su Lucy sulla cultura, Alessia Ragno su L’indipendente e Mark Athitakis sul Washington Post), il libro è anche avvincente dal punto di vista narrativo: è un racconto composto da numerosi personaggi, alcuni dei quali davvero molto riusciti; parla di sentimenti, di amicizia, del senso di impotenza che attanaglia chi cerca di attivarsi, della fatica del dare un senso alla propria vita fra alluvioni, incendi, massacri e conflitti. Insomma, parla di noi, dell’oggi, della distopia quotidiana che ci viene proposta quando accendiamo una radio o una televisione.
Per questo alla fine Diluvio diventa un libro complesso, impegnativo, e non solo per le 1293 pagine nell’edizione italiana (892 nell’edizione originale uscita nel 2022 negli Stati Uniti). Le pagine scorrono veloci, ma lasciano un segno. E sì che il libro racconta una storia limitata agli Stati Uniti, senza approfondire le conseguenti dinamiche nel resto del mondo, e forse questo potrebbe essere visto come un limite dell’opera. Ma certo non può esserci in un solo libro tutto quanto ci sarebbe da dire sulla crisi climatica, neppure Amitav Gosh chiederebbe tanto.
Testo di Stefano Caserini
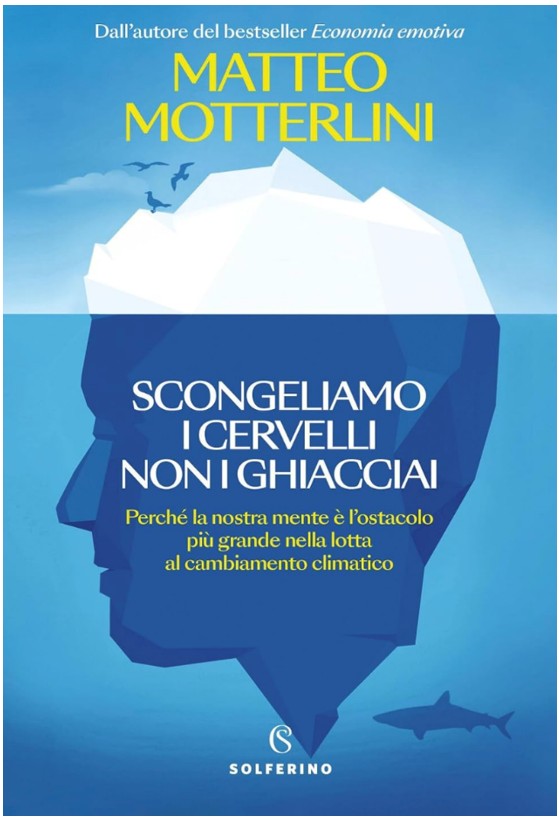
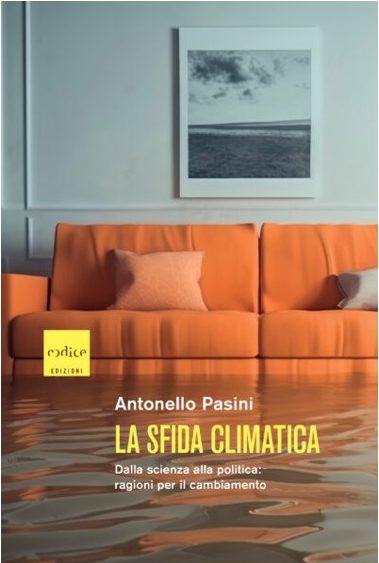
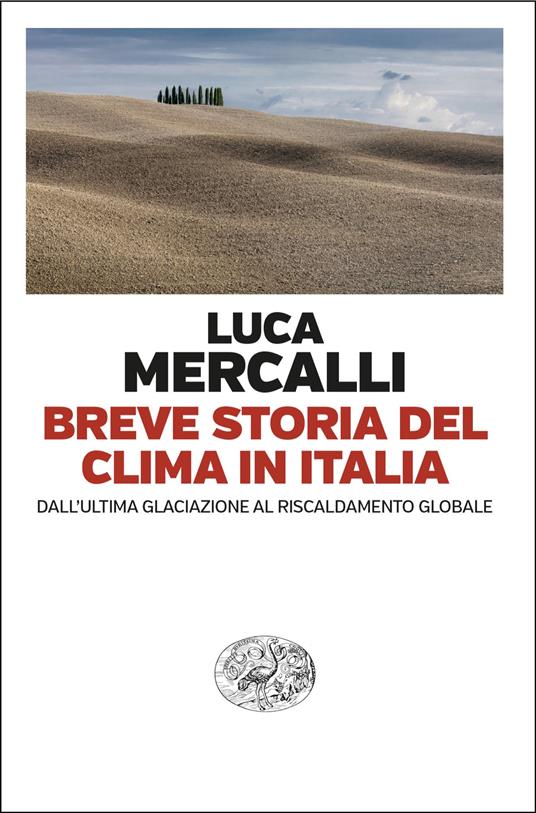



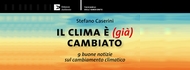
Non è giusyo dire che la letteratura ha dimenticato il cambiamento climatico. Basterebbe citare Ballard. Forse i lettori moderni necessiterebbero di piu fantascienza che pure ha dato grande letteratura.
Gran bel romanzo, il primo capitolo è forse quanto di meglio non sia mai stato scritto, a livello narrativo, sul tema! Nella parte centrale il libro cede un pò, ma poi si riprende e d’altronde è un’opera lunga e complessa!
@Claudio
Certo, Ballard un mito in tal senso!